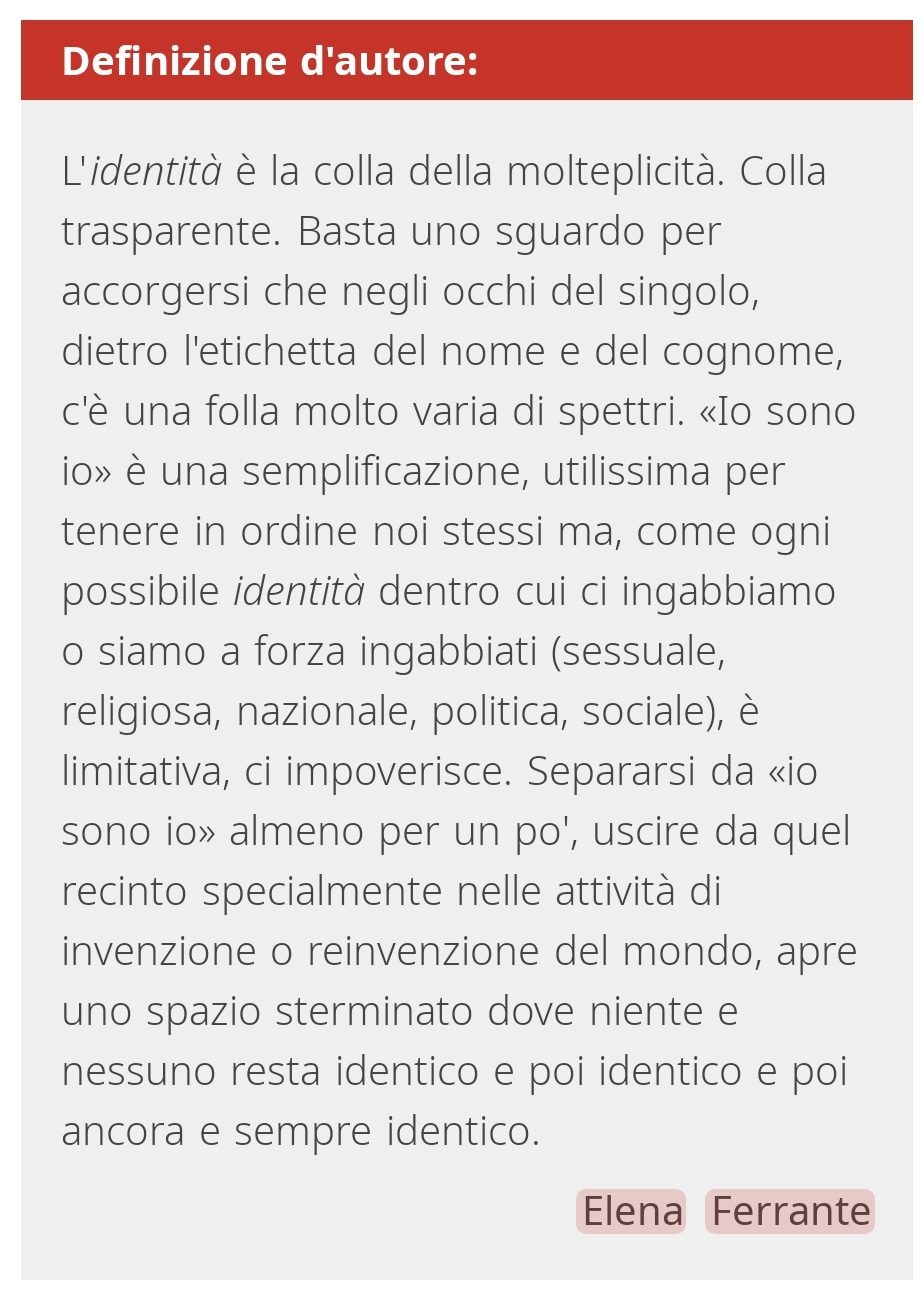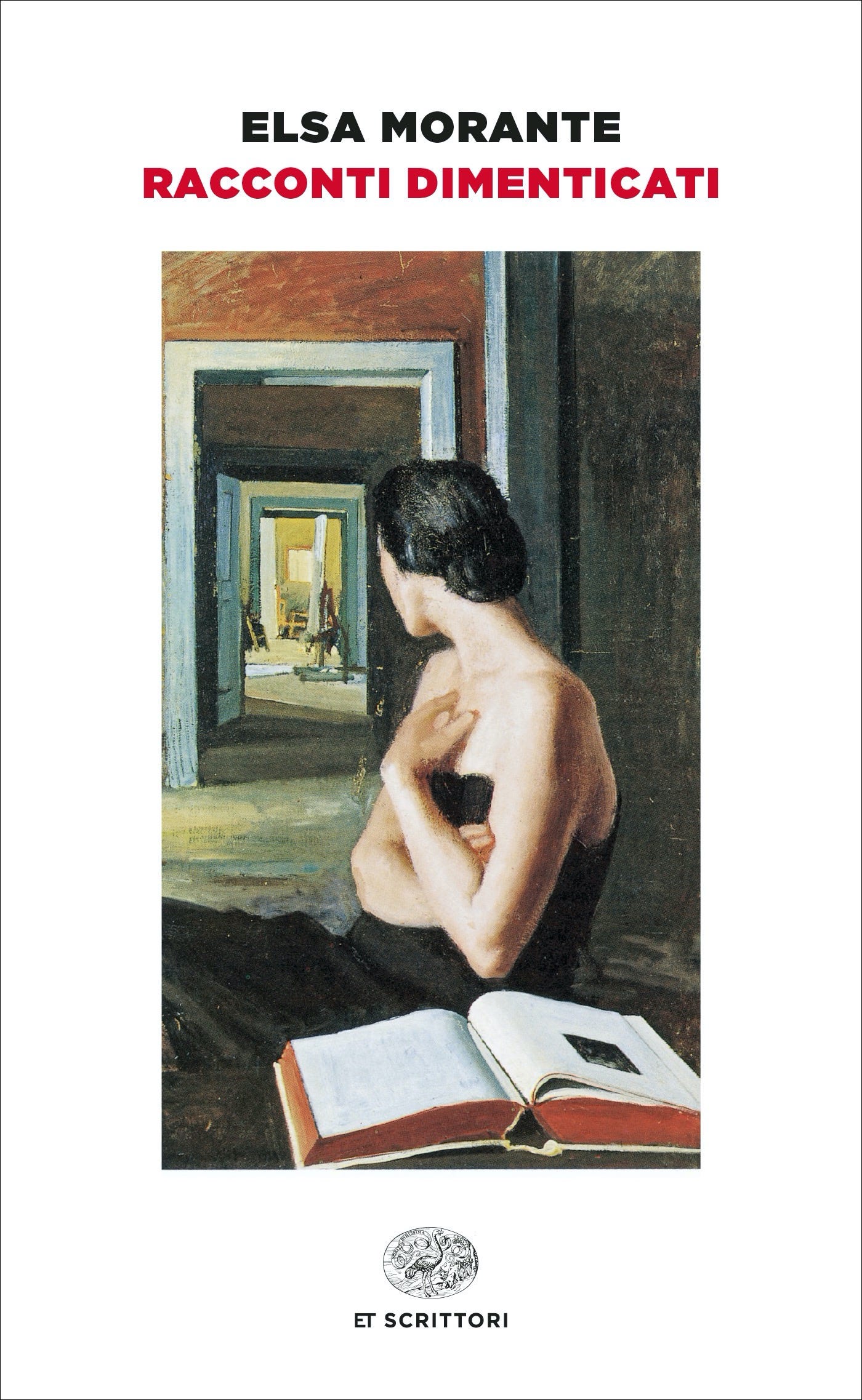Identità di Elena Ferrante, Le case straordinarie di Torino, Tasmania di Paolo Giordano, Francesco Permunian, Il cocchiere di Elsa Morante, Giacomo Leopardi
Buongiorno e buona fine settimana.
Definizione d'autore: identità, Elena Ferrante
Zanichelli 2022
Le case straordinarie di Torino. I segreti dei luoghi che hanno fatto la storia della città di Laura Audi
Ogni casa ha la sua storia, ogni storia ha la sua casa
Passeggiando tra le vie di Torino si ha la sensazione di attraversare una città “segreta”, visibile solo agli occhi di chi si guarda intorno con attenzione. Così – camminando con il naso all’insù – si scoprono le grandi dimore nobili dalle facciate barocche, ricche di dettagli indecifrabili e misteriosi, e si scorgono i palazzi più antichi che in passato sono stati lo sfondo delle vicende dei personaggi più curiosi, tanto che ancora oggi sembrano vibrare di un’energia propria. Passando dalla storia al mistero, si arriva poi sino alle magnifiche ville sulla collina di Torino, conosciute anche per essere state il set ideale dei film di Dario Argento. Sono ancora oggi luoghi splendidi ma abbandonati e sovente temuti per l’alone di magia che li circonda.
Infine l’arte e i suoi protagonisti: una Torino metafisica, come quella dipinta da De Chirico, si delinea nelle dimore dei grandi artisti contemporanei. Da Casa Mollino allo studio di Carol Rama, fino a Casa Mastroianni in collina, esiste un percorso nell’anima più segreta e contemporanea della città. È possibile ammirare un dettaglio, una curiosità, qualcosa di costantemente sfuggevole che scatena quella “sabaudaje” della città, lasciandoci con la voglia di tornare a Torino con la consapevolezza che ci sarà sempre qualcosa di nuovo da scoprire.
Il posto delle parole: A stile libero, Uberta Zambeletti
Sono stata fortunata, la mia genesi è intrisa del culto della bellezza: una bellezza ricercata e consapevole come era quella di entrambe le mie nonne.
D’estate, la nonna Carla, ramo paterno, passava ore il mercoledì e il sabato mattina nel tinello della casa di campagna a preparare giganteschi bouquet di gladioli, dalie, zinie, rose e bocche di leone, freschi di recisione, da distribuire in tutte le stanze. La coreografia di questa fragrante e allegra consuetudine la vedeva protagonista, mimetizzata in perfetto pendant, con lunghe camicie da notte in coordinato con la vestaglia a colori sgargianti, a volte quasi fluorescenti.
Carla era una donna curiosa, intelligente ed estremamente avventurosa. Nel 1962 si imbarcò su un transatlantico per andare in Giappone. Visitò l’India numerose volte, il Nepal, lo Sri Lanka, la Birmania e Israele, oltre naturalmente a gran parte dell’Europa. Mi diceva sempre che il suo paese preferito era la Cambogia. Il mondo non doveva avere segreti per lei: conosceva città e borghi, musei e chiese, spiagge e montagne. Da giovane imparò ad andare a cavallo durante un viaggio in Irlanda. Era sciatrice, golfista, tennista, nuotatrice, adorava fare snorkeling.
Dipingeva porcellane, creando set da tavola completi, giocava a carte, si interessava all’andamento del mercato azionario, era poliglotta e vivacissima, occhi azzurri penetranti e una erre moscia dal suono inconfondibile. Altresì la nonna Linda aveva viaggiato e vissuto all’estero: Buenos Aires, Berlino e Londra. Poliglotta pure lei, colta e vorace, fu pioniera nel cimentarsi nella cucina salutare, traduceva testi dall’italiano al tedesco – ricordo che citava sempre l’amato Dürer, suo pittore prediletto – e fu anche musa di Marcello Dudovich, mitico illustratore della Belle Époque. Dopo la guerra, con sua cugina Ida, aveva fondato un circolo culturale con tanto di biblioteca circolante nel centro di Milano. Si chiamava Il Carosello ed era una specie di bookcrossing ante litteram. In seguito, mentre si dedicava all’antica arte giapponese dell’Ikebana, venne chiamata come buyer di antiquariato dalla Rinascente e cominciò a girare l’Europa incaricata di scegliere i pezzi più interessanti.
Mi piace pensare che siano state Carla e Linda a trasmettermi anche involontariamente curiosità e senso estetico, elementi che hanno sempre fatto parte di me, del mio mondo fisico e mentale. Con questo bagaglio indotto ho imparato ad apprezzare l’arte che illumina e ispira, la letteratura che descrive sentimenti e percezioni, la musica che, pur usando un unico senso, riesce a stravolgerli tutti. Per lungo tempo mi è sempre sembrato naturale pensare che le cose belle piacciono a tutti. Poi, qualche anno fa, un incontro mise in discussione quest’idea. Frequentavo un uomo molto intelligente e brillante, davvero sagace e colto. Peccato che, osservando come si vestiva e andando a casa sua, mi resi conto che non possedeva alcun senso estetico: l’ingresso sfociava direttamente in cucina e il complemento d’arredo in pole position era il bidone della spazzatura. Scoprire che al mondo c’è gente che si copre più che vestirsi, che compra le prime lenzuola che vede a prezzo da discount senza pensare che dentro quei colori tristi, quelle stampe controverse raffiguranti elefanti al tramonto, ci passerà ore della propria vita, mi destabilizzò. Cominciai a provare una sorta di senso di colpa, come se possedere un’innata vocazione al bello fosse discriminatorio e classista, come se giudicare il mondo guidata da lenti estetiche non fosse corretto, e neanche etico. Ho iniziato a documentarmi, ho letto saggi, mi sono bevuta un’intera collana di dvd della BBC sulla storia dell’estetica. Il libro che mi ha illuminato definitivamente si intitola Cinque meditazioni sulla bellezza di François Cheng, filosofo cinese naturalizzato francese e membro dell’Académie Française.
Attraverso la storia della sua infanzia, l’incontro con l’arte figurativa occidentale e altri riferimenti fondanti, uno tra tutti il celebre grido «la bellezza salverà il mondo» di Dostoevskij, Cheng arriva a una conclusione che, istintivamente, già sentivo mia e placò i miei tormenti: «Ogni essere umano è virtualmente abitato dal desiderio di bellezza. L’universo non è tenuto a essere bello, eppure lo è.» Questo dato oggettivo si accorda, proprio come uno strumento musicale, con i sentimenti dei singoli e crea per ognuno di noi una soggettiva interpretazione della bellezza. Il mio diapason personale oscilla di continuo, sfida i confini canonici, smonta le simmetrie, accosta ciò che è ritenuto classico al kitsch. Per esempio, la roulotte di Moira Orfei è un emblema di tale coerenza e personalità estetica che me ne fa innamorare. Michèle Lamy, la compagna e musa di Rick Owens, che ha scelto un’avvenenza provocatoria e grottesca, è divina ai miei occhi perché ogni sua scelta è frutto di un pensiero, di una decisione, di conoscenza profonda di sé e del mondo. David Bowie era un maestro di questo tipo di equilibrio: giocava continuamente tra regole e rivoluzioni, tra convenzioni e provocazioni.
Ci sono capi ufficialmente brutti o banalmente anonimi che possono diventare belli se vengono spostati dal loro contesto tradizionale. Personalmente amo i grembiuli da cucina, ne ho una collezione e li indosso sopra i vestiti, anche per andare a un cocktail. Possiedo abiti da uomo, vecchie divise, maglioni pieni di buchi e di macchie indelebili: ognuno ha una storia ed è il desiderio di raccontarla che li rende e ci rende speciali. Siamo esseri complessi: siamo rose con le spine e api assassine capaci di produrre il miele più dolce. Inseguire la bellezza significa cimentarsi con l’ambiguità di ogni aspetto della vita. La consapevolezza e la capacità di comporre uno stile, il proprio, con coraggio e senza pregiudizi, può diventare un vero viatico per la gioia. Non è mai una questione di possibilità economiche. Lo dico con cognizione di causa perché ho aperto undici anni fa un negozio, Wait and See, che ha fatto della politica «il lusso non sta nel prezzo» una delle sue regole fondanti. Conta la creatività, tutta la fantasia che ciascuno di noi, ogni mattina, può mettere nel gesto quotidiano di vestirsi.
VA TUTTO BENE
Appena sposati, i miei genitori andarono a vivere a Londra, dove sono nata io. Mio padre era rammaricato che non fossi quel primogenito maschio in cui sperava. Invece io ero femmina, bruttina e con il naso schiacciato. Il suo primo commento fu che il mio naso sembrava il cofano di una Porsche. Undici mesi dopo è nato mio fratello Leopoldo. Maschio, bello e vivace, tanto quanto io sarei stata per molti anni cupa e solitaria, sempre a disagio, a casa e a scuola. Avevo pochi mesi quando ci trasferimmo a Madrid. Mio nonno aveva deciso di spedirci mio padre perché aprisse la sede spagnola dell’azienda di famiglia. La Spagna, allora, era ancora sotto la dittatura del generale Francisco Franco.
Quando i miei arrivarono a Madrid, si respirava un’aria plumbea e repressa. Le donne si vestivano di nero, erano sempre accollatissime, mentre in Italia l’atmosfera era già molto diversa. A quel punto, seconda metà degli anni Sessanta, da noi erano visibili gli effetti delle rivoluzioni di costume arrivate dagli Stati Uniti e dalla Londra dei Beatles e di Mary Quant. Le donne indossavano le minigonne, si preparavano all’arrivo degli anni Settanta. In Spagna erano ancora intrappolate nel passato. Ovviamente, tutte queste cose le ho capite dai racconti successivi dei miei genitori, ero troppo piccola per rendermene conto. Uno dei momenti precisi di cui ho però memoria riguarda proprio el Caudillo. Una mattina mia madre venne a chiamare me e mio fratello per avvisarci che il generale Francisco Franco era morto. Era il 20 novembre 1975. Per noi fu un giorno di gioia: l’alibi perfetto per saltare l’odiata scuola. Abitavamo in calle Espalter, poco lontano dal museo del Prado e dal parco del Retiro. Ci portavano tutti i pomeriggi. Vestiti come gemelli con cappottini in tweed celeste con collo e tasche in velluto in nuance, bianche ghette in lana che coprivano le scarpe e candidi passamontagna. Salivamo sugli alberi e davamo da mangiare pane secco alle anatre del laghetto. Veniva sempre con noi il bassotto Filippo. Ricordo ancora quando un anziano signore si inalberò allo scoprire che il cane portava il nome dell’erede al trono, Felipe, oggi re di Spagna.
Elogio dell’aberrazione di Francesco Permunian
I demoni vociferanti (quasi un prologo)
Prima di imbarcarmi in questa nuova intrapresa dall’esito incerto e forse inattendibile – prima di redigere cioè un ragionevole inventario di cose e persone del mio recente passato –, forse avrei fatto bene a pensarci due volte. E, magari, a tacere. A non svelare taluni altarini domestici, evitando in tal modo di aprire l’armadio dei ricordi. Che è gonfio e rigonfio di fantasmi talmente immondi e osceni da chiedermi se e come sia mai possibile imporre il bavaglio a certi demoni. Se e come, ripeto, siano albergate in me, nella mia testa bacata, delle passioni così sfrenate e aberranti da non potersi neppure nominare con umane parole, né tantomeno riferire in sede pubblica. E dunque, che cosa ho fatto?
Mi sono tappato il naso davanti a certe lordure e poi, armato di buona volontà, ho riunito da qui in avanti una serie di molteplici figure e figurine – qualcuna provvista di una mediocre notorietà di provincia, come nel caso del direttore del mio giornale, qualcun’altra rassegnata invece al plumbeo grigiore dell’anonimato (mi riferisco a me stesso) – le quali hanno tutte in comune un solo e unico denominatore. Un unico e solo destino: quello di non essere fatte di carne e d’ossa, come noi miseri mortali, ma di possedere l’incorruttibile e volatile consistenza dei sogni fatti all’alba.
Peter Pan
Dopo un tale preambolo fin troppo lungo e cerimonioso – ma con certi signori delle tenebre il cerimoniale è d’obbligo – rompiamo gli indugi e spendiamo due parole sul conto del sottoscritto. Non per vanità, sia beninteso. Bensì per chiarire, e possibilmente circoscrivere, l’infida ed evanescente sostanza di quanto andrò a raccontare. Pronuncerò quindi il mio nome, come si fa quando ci si presenta in pubblico. E a maggior ragione, davanti a un pubblico di attenti e smaliziati lettori. Orbene, sia all’anagrafe che al fonte battesimale, a me venne imposto il nome di Tito. Tito Maria Imperiale, per servirvi.
Anche se di imperiale o di regale non c’è davvero traccia nella mia persona, tant’è che tutti mi conoscono come el sior Titìn per via di una non eccelsa complessione strutturale che a malapena sfiora il metro e sessanta. Non sono un Adone, diciamolo pure. Né mai lo sono stato, avendo un indice di massa corporea pressoché invariato fin dai tempi dell’adolescenza. Ciò nonostante, malgrado siffatta insignificanza fisiologica (malignano che io assomigli, a parte i baffetti, al nostro defunto e non compianto Re Pipetta), vengo abitualmente reputato un tipo tosto e tenace. E, se messo alla prova, più resistente del fil di ferro pur sembrando un filo di spago che dondola e tentenna alla prima brezza autunnale. In realtà, ben pochi mi conoscono. Pochi sanno veramente di me, a parte la bella e volubile Ofelia Del Pirón, mia compagna e complice in giochi e giochini erotici: che male c’è, in fondo, a essere dei coprofili? Mica è un peccato divertirsi con le proprie feci, dopo tutto è roba nostra.
Materia organica di nostra esclusiva proprietà, voglio vedere chi ha il coraggio di sostenere il contrario. Vorrei proprio vedere la faccia di chi ci sorprendesse per caso, me e Ofelia, mentre giochiamo ad acchiapparella tirandoci dietro pezzi di merda e rotoli di carta igienica dentro la casa ridotta a un lurido cesso. Siamo due giocherelloni. Due eterni Peter Pan, e con ciò? Comunque, per non dare adito a pettegolezzi, appena sposati abbiamo deciso di comune accordo di non mettere al mondo dei figli. L’abbiamo fatto per un’ovvia ragione, ovvero per non ritrovarci tra i piedi dei piccoli intrusi che un giorno – non si sa mai – ci avrebbero potuto giudicare e magari denunciare per atti osceni contro madre natura. O forse, più semplicemente, l’abbiamo fatto spinti dal calcolo e dalla pietà. E se oltre alla coprofilia, ci siamo chiesti, ci fossimo spinti a praticare anche il cannibalismo pur di levarci lo sfizio di fare a pezzi la nostra progenie? Meglio allora non rischiare di finire in carcere o rinchiusi in qualche manicomio come accadde al povero Sade, che dio ne scampi!
Fu, la nostra, una soluzione genitoriale nient’affatto sofferta e traumatica. Fu, oggettivamente, una decisione più che sensata. Senza alcun dubbio la migliore soluzione che io e Ofelia potessimo prendere per non turbare il nostro tranquillo ménage coniugale. A parte infatti talune trascurabili eccezioni alla morale sessuale corrente consistenti in reiterate pratiche stercorarie (da non ritenersi, a parer mio, delle anomalie comportamentali né tantomeno delle perversioni), a parte tutto ciò, dicevo, io e mia moglie siamo pur sempre due rispettabili cittadini al di sopra di ogni sospetto e diceria. E siamo, oltretutto, particolarmente devoti a Maria Margherita Alacoque, la nostra santa di riferimento. La nostra santa protettrice. Perciò ogni domenica mattina, di regola, noi ascoltiamo Messa. La Messa cantata delle undici e trenta, quella più bella e prestigiosa.
Quella a cui assistono tutti i signori del paese. Il nostro banco nel duomo è uno dei primi sulla destra, giusto di fianco a quello dei miei nonni Augusto e Pasquina, devoti e religiosi quanto noi. Noi che tuttavia, a differenza di loro, indossiamo la maschera domenicale dei bravi cristiani affinché nessuno si sogni di smascherare i nostri vizietti privati. Onde sgombrare il campo da ipotesi o deduzioni fuorvianti, mi siano consentite infine due brevi annotazioni di ordine storiografico. La prima riguarda l’insolito cognome della mia consorte – Del Pirón, ma anche, erroneamente, Dal Pirón – per il quale qualcuno prospetta delle origini invero assai modeste. Se non addirittura plebee, rifacendosi al celebre detto popolare «el codeghin lo ga empirà col pirón», ossia, «ha infilzato il cotechino con la forchetta». Il che, se fosse vero, rimanderebbe senza appello a quella benedetta carne di maiale di cui fu grande esperto il fratello di Ofelia, mister Tamarindo, di cui si dirà fra non molto.
Questa però è soltanto l’opinione di qualche mediocre cultore di storia locale. Niente di più, una vulgata che non corrisponde affatto alla mia personale convinzione partorita dopo lunghe ricerche archivistiche sia in Italia che all’estero. Secondo le quali il cognome in questione discenderebbe – e sfido chiunque a dimostrare il contrario! – da un ramo cadetto dei Pirón, un’antichissima casata delle Fiandre che esibisce sullo stemma una scrofa spiegata di nero. Ora, benché io non sia un esperto di araldica, non ho avuto alcuna difficoltà nel riconoscere in quella scrofa grufolante il destino, già scritto e segnato, di Tamarindo e di Ofelia Del Pirón. Lui, tutto roseo e ben pasciuto come un porcellino, con un futuro da chef specializzato in carni suine; lei, con quel suo sguardo «fiammingo» vagamente allucinato, che si avvoltola tra i suoi stessi escrementi stringendo al petto un santino della Alacoque che la incita a mangiarli. La seconda considerazione non ha invece nulla a che vedere con l’araldica, bensì con la mistica. E, nello specifico, con quelle forme di misticismo urinario e stercorario di cui suor Maria Margherita Alacoque (Verosvres, 22 luglio 1647-Paray le Monial, 17 ottobre 1690) fu una delle massime esponenti in ambito europeo.
Tasmania di Paolo Giordano
Ci sono momenti in cui tutto cambia. Succede una cosa, scatta un clic, e il fiume in cui siamo immersi da sempre prende a scorrere in un’altra direzione. La chiamiamo crisi.
Il protagonista di questo romanzo è un giovane uomo attento e vibratile, pensava che la scienza gli avrebbe fornito tutte le risposte ma si ritrova davanti un muro di domande. Con lui ci sono Lorenza che sa aspettare, Novelli che studia la forma delle nuvole, Karol che ha trovato Dio dove non lo stava cercando, Curzia che smania, Giulio che non sa come parlare a suo figlio. La crisi di cui racconta questo romanzo non è solo quella di una coppia, forse è quella di una generazione, sicuramente la crisi del mondo che conosciamo – e del nostro pianeta.
La magia di Tasmania, la forza con cui ci chiama a ogni pagina, è la rifrazione naturale fra ciò che accade fuori e dentro di noi.
Cosí persino il fantasma della bomba atomica, che il protagonista studia e ricostruisce, diventa un esorcismo: l’apocalisse è in questo nostro dibattersi, e nei movimenti incontrollabili del cuore.
Raccogliendo il testimone dei grandi scrittori scienziati del Novecento italiano, Paolo Giordano si spinge nei territori piú interessanti del romanzo europeo di questi anni, per approdare con felicità e leggerezza in un luogo tutto suo, dove poter giocare con i nascondimenti e la rivelazione di sé, scendere a patti con i propri demoni e attraversare la paura.
«Se proprio dovessi, sceglierei la Tasmania. Ha buone riserve di acqua dolce, si trova in uno stato democratico e non ospita predatori per l’uomo. Non è troppo piccola ma è comunque un’isola, quindi facile da difendere. Perché ci sarà da difendersi, mi creda».
Tasmania è un romanzo sul futuro. Il futuro che temiamo e desideriamo, quello che non avremo, che possiamo cambiare, che stiamo costruendo. La paura e la sorpresa di perdere il controllo sono il sentimento del nostro tempo, e la voce calda di Paolo Giordano sa raccontarlo come nessun’altra. Ci ritroviamo tutti in questo romanzo sensibilissimo, vivo, contemporaneo. Perché ognuno cerca la sua Tasmania: un luogo in cui, semplicemente, sia possibile salvarsi.
Racconti dimencati: Il cocchiere di Elsa Morante
Ero studente e fui invitato a trascorrere le vacanze in una casa vetusta e remota. Sapevo che amavano frequentarla gli spettri e infatti subito la prima notte li udii. Si trattava di spettri dalla natura benigna; battevano sui vetri qualche tocco discreto, e facevano scricchiolare le finestre e ballare il letto, ma solo quanto bastava a conciliare il sonno. Nel cuor della notte, però, udii una voce di basso cantare una canzone in voga nel paese quarant’anni prima: «Doman doman Domenica | a caccia me ne vo». Questa voce aveva un che di beffardo, e, nella sua monotonia, certe note che facevano gelare il sangue. Pure una nefasta curiosità mi vinse, e decisi di vedere coi miei occhi da quale corpo uscisse la canzone. Scesi dunque dal letto, e lungo i neri corridoi tenni dietro al filo di quella voce. Non mi lasciai spaventare né dai soffi che al mio passaggio mi ventavano addosso, né dai fischi brevissimi che si chiamavano su per le pareti; giunsi infine all’uscio socchiuso di una stanza illuminata, e, prima ancora ch’io domandassi di entrare, quella stessa voce ordinò: – Avanti! Avanti!
Appena entrato fui deluso, perché mi trovai semplicemente in presenza del vecchio giudice, lo zio dei miei ospiti, che abitava un’ala del palazzo. Lo riconobbi subito, sebbene egli non comparisse mai né a tavola né in salotto, e si limitasse a sporgere la testa dalla finestra del giardino con un sorriso ironico e sornione, o ad attraversare le stanze nella sua comoda e consunta vestaglia scozzese e nelle sue silenziose pantofole. I miei ospiti non amavano troppo di presentarlo agli amici o di parlare di lui; si erano limitati ad accennarmi che in gioventú era stato un buontempone e che era un originale. Il suo carattere, mi spiegarono, aveva subito una forte scossa in seguito alla morte di un suo vecchio cocchiere, il quale, scacciato da lui dopo trent’anni di servizio, era, se cosí ci è permesso di esprimerci, crepato nella miseria.
In quel momento, il giudice stava seduto sul letto, con le coltri e le lenzuola ammonticchiate ai piedi. Portava una semplice maglia di lana, mutande e corpetto, che gli aderiva alle membra e, chiusa da fettucce alle caviglie, lasciava scoperti solo i suoi piedi nudi e il principio del suo petto villoso. Era un vecchio di statura gigantesca e piuttosto pingue, con le guance cascanti e pallide, due baffoni ingialliti dal tabacco, grossi sopraccigli su palpebre pesanti, e un’argentea, folta chioma. Se ne stava sotto i drappeggi dell’alcova, nella camera sudicia e sconvolta di cui l’illuminazione sfarzosa faceva brillare ogni granello di polvere sui mobili tarlati e sui brandelli di tappezzeria.
– Scusate, eccellenza, – balbettai. – Mi sorprendete, – rispose ammiccando, – nel mio négligé –. Pensai che fosse mio dovere ritirarmi, ma egli mi richiamò con autorità:
– Restate, giovanotto. Noi già ci conosciamo, mi pare.
– Infatti, ho l’onore… – dissi. Capivo ora, all’udire il suono della sua voce, perché i miei ospiti evitassero di presentarlo in salotto. – Certo, – egli seguitò con una lenta smorfia, – è stata la mia canzoncina che vi ha svegliato. È una canzoncina, – soggiunse battendo il tempo con la mano, – proprio adatta per accompagnare il trotto dei cavalli. Sentite:
Doman doman Domenica
a caccia me ne vo.
– Davvero! – dissi. – La canticchio sempre quando lavoro, – egli mi confidò strizzando l’occhio, – perché io sono cocchiere, di professione cocchiere.
– Ah, ecco, – balbettai. Non capivo se egli volesse scherzare o se la sua «originalità» consistesse appunto nel credersi diventato quel suo cocchiere morto per colpa sua molti anni prima. – Già, – confermò, – o, per meglio dire, io facevo il cocchiere. Il vecchio mi licenziò, e giuro che lo fece per avversione e vergogna, perché avevo visto troppe cose. Il vecchio era un peccatore e un libertino!
– Ma no, che dite, – cercai d’intromettermi.
– Un libertino! – gridò piú forte. – E – proseguí – quando fui scacciato, sapete io che feci? Mi nascosi di notte nella sua camera, con la pistola carica, e pam! pam! gli scaricai la pistola nella pancia.
Ebbe a questo punto una risatina grassa e saltellante. – Essi, – mi spiegò divertito accennando ai parenti nella casa, – non sanno che sono morto.
E la sua voce nasale e tremula, orribilmente musicale, si levò di tono: – Siamo dannati tutti e due, – disse atterrito, – cocchiere e padrone, in eterno corriamo sulla carrozza, per una tempesta nera, e non arriveremo mai! Avanti, avanti, cavalli!
Fu qui che coi miei occhi vidi l’alcova invasa da una bufera di vento, e, tutto restando immobile e tranquillo intorno a me nella camera, le ciocche bianche del vecchio agitarsi furiose, i suoi denti urtarsi, la sua pelle illividire, e lenzuola e drappeggi sbattere come le vele di un vascello sconvolto. Allora con un grido mi precipitai fuori da quella stanza.
Zibaldone di pensieri: Allegrezza e Tristezza di Giacomo Leopardi
Dev’esser cosa già notata che come l’allegrezza ci porta a communicarci cogli altri (onde un uomo allegro diventa loquace quantunque per ordinario sia taciturno, e s’accosta facilmente a persone che in altro tempo avrebbe o schivate, o non facilmente trattate ec.) così la tristezza a fuggire il consorzio altrui e rannicchiarci in noi stessi co’ nostri pensieri e col nostro dolore. Ma io osservo che questa tendenza al dilatamento nell’allegrezza, e al ristringimento nella tristezza, si trova anche negli atti dell’uomo occupato dall’uno di questi affetti, e come nell’allegrezza egli passegia2 muove e allarga le braccia le gambe, dimena la vita, e in certo modo si dilata col trasportarsi velocemente qua e là, come cercando una certa ampiezza; così nella tristezza si rannicchia, piega la testa, serra le braccia incrociate contro il petto, cammina lento, e schiva ogni moto vivace e per così dire, largo. Ed io mi ricordo, (e l’osservai in quell’istesso momento) che stando in alcuni pensieri o lieti o indifferenti, mentre sedeva, al sopravvenirmi di un pensier tristo, immediatamente strinsi l’una contro l’altra le ginocchia che erano abbandonate e in distanza, e piegai sul petto il mento ch’era elevato.
Grazie per aver letto, a presto.
Nat